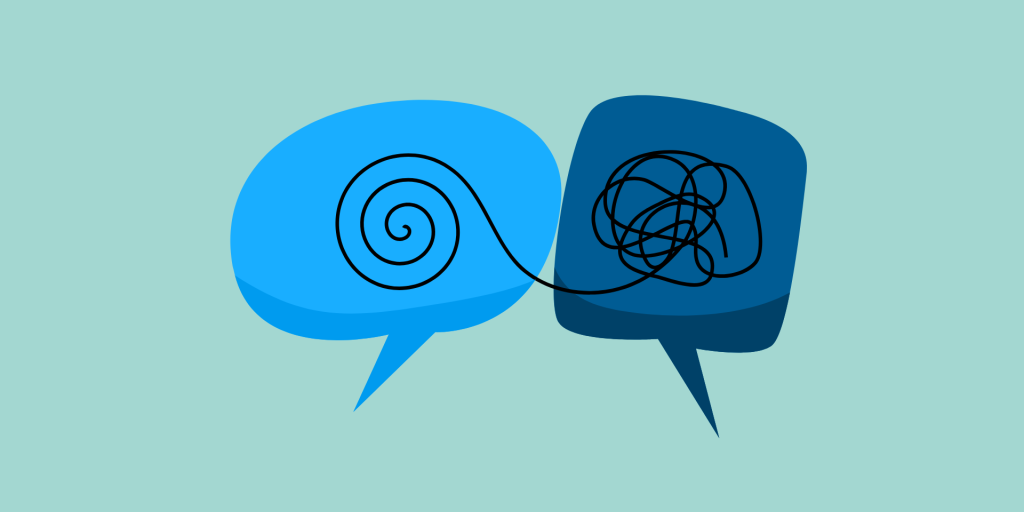È vero: non sempre la terapia funziona. Ma perché? Vediamo insieme ciò che spesso ostacola un percorso terapeutico. Per farlo ho stilato una lista di punti che smonta il mito della terapia come “processo magico” o passivo, restituendole la sua natura di lavoro collaborativo.
Questi punti evidenziano che la terapia non fallisce quasi mai per mancanza di “tecnica”, ma per una rottura o un’imprecisione nell’alleanza terapeutica. Ecco 7 motivi per cui la terapia non funziona.
1) Obiettivi poco chiari, non definiti o non condivisi
La terapia non è un percorso a senso unico. Se non è chiaro cosa si vuole cambiare, cosa si sta cercando o cosa significhi “stare meglio” per quella persona, il lavoro rischia di diventare vago, ripetitivo e frustrante. A volte gli obiettivi restano impliciti, vengono dati per scontati o non vengono mai davvero negoziati. Quando terapeuta e paziente lavorano con mappe diverse, è facile avere la sensazione di non andare da nessuna parte o di andare in due direzioni diverse. Parlare apertamente degli obiettivi è un atto di cura verso il percorso. Il paziente è sempre parte attiva del processo, partendo proprio dalla definizione condivisa degli obiettivi terapeutici.
2) La difficoltà a dire al terapeuta che qualcosa non sta funzionando
Alcune persone evitano di dire:
• “Non mi sento capito.”
• “Non so se questo lavoro mi sta aiutando.”
• “Ho dei dubbi su come stiamo lavorando.”
Non lo dicono per paura di deludere, di sembrare ingrati o di creare tensione nella relazione. Possiamo chiamarlo il paradosso della “Buona Educazione”. Molti pazienti portano in terapia lo stesso schema che usano fuori: il bisogno di essere “bravi pazienti”, di compiacere il terapeuta o di non creare conflitti. Il rischio è che se non dici al terapeuta che ti ha infastidito o che non ti senti capito, stai portando in seduta una “maschera”. L’opportunità invece risiede nel fatto che la prima volta che un paziente dice “Oggi non sono d’accordo con lei” o “Questa seduta non mi sta servendo”, è lì che spesso la vera terapia inizia. È un esercizio di assertività in un ambiente protetto. La terapia è uno spazio sicuro che può reggere anche il dissenso, la delusione e la fatica. Quando queste emozioni non vengono portate in seduta, il lavoro si impoverisce. Dire che qualcosa non funziona è parte della terapia, non un suo fallimento. Anzi può essere un importante fattore trasformativo che permette di portare la guarigione al passo successivo.
3) Aspettare che il cambiamento avvenga “da solo”
La terapia non è qualcosa che si subisce, ma qualcosa a cui si partecipa. Quando il cambiamento viene vissuto come responsabilità esclusiva del terapeuta o come qualcosa che dovrebbe accadere solo parlando, il percorso tende a bloccarsi. Il passaggio dalla visione del paziente come “contenitore passivo” di cure al paziente come protagonista attivo è fondamentale al fine della buona riuscita della terapia.
L’idea del terapeuta come “risolutore magico” dotato di bacchetta magica in grado di guarire è un retaggio che purtroppo spesso danneggia il percorso, perché sposta il potere (e quindi la responsabilità) fuori dalla persona in cura. Se il potere è tutto nelle mani del terapeuta, il paziente resta impotente. Invece il concetto di agency, la sensazione di poter fare qualcosa, anche di piccolo, è un ingrediente fondamentale del cambiamento psicologico. Anche il micro cambiamento che avviene per step ha grande valore! Non serve sempre una rivoluzione totale per allenare la capacità di incidere sulla realtà. Il terapeuta va dunque visto come un navigatore e non come un pilota. Restando dentro alla metafora in un viaggio in auto il paziente è alla guida e il terapeuta siede sul sedile del passeggero con la mappa. Il terapeuta può suggerire una strada più veloce, avvertire di un pericolo o spiegare perché il motore sta facendo un rumore strano. Ma le mani sul volante e il piede sull’acceleratore sono del paziente. Se il paziente smette di guidare, l’auto si ferma, indipendentemente da quanto sia bravo il navigatore.
4) Non fare i “compiti”
Quando vengono proposti esercizi, osservazioni o piccoli esperimenti tra una seduta e l’altra, servono a portare la terapia nella vita reale, interrompere automatismi e costruire esperienza, non solo comprensione. In genere vengono sempre concordati tra paziente e terapeuta. Non farli può rallentare molto il processo. Se i compiti sembrano troppo difficili o poco chiari o si fatica a capirne il senso, è importante dirlo, non semplicemente evitarli. Altrimenti è come lavorare per il cambiamento solo quell’ora in cui si fa terapia e basta. La settimana ha 168 ore. Se la terapia dura solo un’ora, restano 167 ore in cui i vecchi schemi agiscono indisturbati. I “compiti” non sono verifiche scolastiche, ma ponti. Se un paziente non li fa, il dato più interessante non è il compito mancato, ma il perché (resistenza, paura, noia, obiettivo non condiviso). Analizzare il “non fatto” è materiale terapeutico preziosissimo.
5) Restare nella comprensione, senza passare all’esperienza
Capire perché si sta male è importante, ma spesso non è sufficiente. La terapia può bloccarsi quando si parla molto, si analizza tutto, ma non si sperimentano nuovi modi di sentire, pensare e agire. Il cambiamento avviene quando qualcosa viene vissuto in modo diverso, non solo compreso. Si tratta del Sapere contro il Sentire. C’è una grande differenza tra la comprensione intellettuale (“Capisco che soffro perché i miei genitori erano assenti”) e l’esperienza emotiva (“Sento ora il vuoto di quella assenza”). La comprensione è una forma di controllo: pensiamo che se “capiamo”, il problema sparirà. Ma il cambiamento avviene spesso quando si smette di analizzare e si inizia a sentire l’emozione nel corpo, permettendole di trasformarsi.
6) Si rimugina in terapia
Ossia la seduta diventa uno spazio di rimuginio: gli stessi pensieri, le stesse domande, le stesse analisi che si ripetono senza portare cambiamento e portando maggiore sofferenza o ansia. Il rimuginio può essere un sintomo ma se occupa tutto lo spazio della seduta, rischia di tenere lontane le emozioni e di bloccare il processo terapeutico. Per questo è spesso più utile partire da episodi concreti, da situazioni reali della vita quotidiana, piuttosto che restare su riflessioni generali o astratte. Un conto è parlare di qualcosa: è il resoconto dei fatti (cronaca), che spesso alimenta il rimuginio. Diverso invece è parlare con qualcuno: è l’atto di usare la parola per sperimentare nuove verità, per dichiarare un impegno o per sentire l’effetto che fa dire certe cose a voce alta.
È importante allenarsi insieme al proprio terapeuta a riconoscere quando si sta rimuginando, per poter tornare al processo e usare quello spazio in modo più utile e consapevole.
7) Paura del cambiamento (anche quando si dice di voler stare meglio)
Una parte di noi può desiderare il cambiamento, mentre un’altra teme di perdere equilibri conosciuti, di deludere gli altri o si protegge restando nella sofferenza nota. Quando queste parti non vengono riconosciute, la terapia può sembrare ferma, ma in realtà sta incontrando resistenze. Affrontarle permette di interrompere meccanismi di mantenimento importanti. Il processo di cambiamento non è mai un percorso lineare, ma piuttosto una danza complessa tra forze opposte. Una parte di noi può desiderare con forza un’evoluzione, spinta dal dolore o dall’aspirazione a una vita più autentica, mentre un’altra parte — spesso più silenziosa ma estremamente potente — agisce per mantenere lo status quo. Questa resistenza non è un errore o una mancanza di volontà, ma una forma di protezione che affonda le radici nel bisogno di sicurezza e appartenenza. Temiamo di perdere equilibri che, per quanto dolorosi, sono familiari; temiamo di deludere le aspettative altrui o di rompere quelle “lealtà invisibili” che ci tengono legati alla nostra storia passata.
Quando queste parti conflittuali non vengono riconosciute ed esplorate con compassione, la terapia può dare l’impressione di trovarsi in una fase di stallo. In realtà, quell’apparente immobilità è un momento cruciale di incontro con le nostre difese più profonde. Invece di forzare il passo, il lavoro terapeutico diventa allora un’opera di ascolto di ciò che “frena”: comprendere a cosa serve quella sofferenza, quale pericolo sta cercando di evitare e quale prezzo temiamo di pagare per la nostra libertà. Riconoscere queste resistenze significa smettere di combatterle e iniziare a dialogare con esse. Solo quando la parte di noi che ha paura si sente compresa e rassicurata, può allentare la presa, permettendo ai meccanismi di mantenimento di trasformarsi. È attraverso questa integrazione che il cambiamento smette di essere una minaccia all’identità e diventa un’evoluzione naturale, permettendoci di procedere verso il nuovo senza dover necessariamente distruggere il vecchio, ma trasformandolo in una base più solida e consapevole.
Una sintesi
| Ostacolo | Azione correttiva suggerita |
| Obiettivi Vaghi | Chiedere: “Cosa stiamo cercando di ottenere concretamente oggi?” |
| Rimuginio | Portare un esempio specifico accaduto in settimana (chi, cosa, dove). |
| Noia o Frustrazione | Dirlo apertamente: “Sento che oggi stiamo girando a vuoto”. |
| Paura del Cambiamento | Ammettere: “Ho paura di chi diventerò se smetto di stare male”. |
CONSIGLIO: Essere parte attiva e parlare al terapeuta quando si percepisce che qualcosa non va.
Quando la terapia non funziona, spesso non è perché “non serve”, ma perché qualcosa nel processo non è stato messo a fuoco: obiettivi, ruoli, difficoltà, responsabilità condivise.
La buona terapia non è quella che evita le frizioni, ma quella che può accoglierle e lavorarci insieme.
Se cerchi una psicoterapeuta a Bussolengo o online contattami.